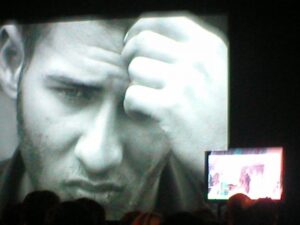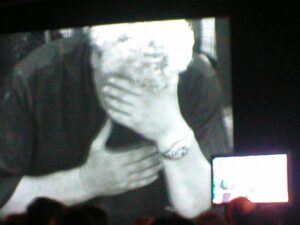Il Ta’ziyè è l’unica forma di drammaturgia tradizionale originata dal mondo islamico.
E’ essenzialmente un teatro rituale – una vera e propria cerimonia di lutto – e la sua forma e il suo contenuto affondano le loro radici profondamente nella tradizione religiosa.
Una rappresentazione sacra con una spiccata tradizione, legata agli eventi tragici della storia dell’Islam, che mette in scena il martirio dell’imam Hossein (nipote del Profeta Maometto, figlio di Alì e secondo imam degli sciiti), accaduto nel VII secolo dopo Cristo. Pur essendo islamico, si tratta di qualcosa di profondamente persiano e trae la sua ispirazione fondamentalmente da questo patrimonio politico e culturale.
L’omicidio di Hossein e l’eccidio di Kerbala furono l’epilogo di una lotta scatenatasi per il controllo della comunità musulmana nascente, all’indomani della morte di Maometto e che sancì la definitiva divisione dei musulmani in sunniti e sciiti.
I primi sposavano la antica tradizione araba della successione per elezione, i secondi desideravano che la successione avvenisse per via ereditaria, sulla base dei legami di sangue col Profeta.
Dal X secolo, quando in Iran e a Bagdad i musulmani sciiti salirono al potere, i gruppi di lutto dell’imam Hossein iniziarono la loro attività in ricordo del martirio.
Dal periodo Safavì, (XV secolo) questa caratteristica forma di rappresentazione scenica s’ispirava inizialmente ai racconti epici di Siyavash dell’Iran antico.
All’inizio della dinastia di Nasserddin Shah nel 1906, furono costruiti più di trenta “tekkiyè”, cioè luoghi delle rappresentazioni del Ta’ziyè.
Lo scià Nasserddin pensò ad un luogo adatto alle rappresentazioni teatrali e costruì uno spazio molto simile all’Albert Hall di Londra. Ma siccome i religiosi si opponevano a questo progetto, egli dedicò questo luogo alle recite del Ta’ziyè. Il “tekkiyè statale”, che molti stranieri paragonarono all’Arena di Verona, era una costruzione di tre piani, rotonda con un raggio di 60 metri e una altezza di 24. Gli attori recitavano il Ta’ziyè su una pedana.
Lo spettacolo non aveva scenografie ed era totalmente narrativo e veniva arricchito nella esecuzione da canti e poesie.
Da quel tempo, è consuetudine che il gruppo che rappresenta la famiglia dell’imam ovvero le anime pure, si vestano di verde, mentre i generali e l’esercito di Yazìd, l’imperatore della terra dell’Islam, si vestano di rosso, con l’obiettivo di aiutare gli spettatori ad identificare i ruoli.
Il rosso è simbolo di sangue e peccato mentre il verde è segno della purezza e dell’innocenza.
Inoltre gli abiti degli attori non sono più quelli del VI secolo, ma del periodo Ghajar (fine Ottocento e inizio del Novecento) quando le storie del Ta’ziyè assunsero la forma di un canovaccio scritto.
Gli Olià (cioè i membri della famiglia dell’imam Hossein) cantano sulle basi della tradizione musicale iraniana, mentre i soldati di Yazìd, Shemr ed Ebne Saad si esprimono attraverso la prosa melodica e non cantano. Di solito il suono di un tamburo accompagna il canto, come pure indica che il dramma sta per cominciare. Secondo molti studiosi è grazie proprio al Ta’ziyè che gran parte del repertorio musicale persiano classico è pervenuto fino a noi.
Il Ta’ziyè che nel tempo assunse una sua costruzione drammaturgica, si adattò anche per le recite comiche e per drammi di altro contenuto, ma non modificando la sua struttura per le vicende che raccontavano l’eccidio nella pianura di Karbala, compresi i testi di Soleyman Nabi o Hallaj, un filosofo del X secolo.
In questo modo il dramma musicale religioso maturò in Iran. E a tutt’oggi, nessun paese musulmano ha una forma drammaturgica così solida.
Uno dei maggiori scrittori di Ta’ziyè è Mostafà Kashanì.
E in questo spettacolo abbiamo attinto ai suoi scritti soprattutto nei dialoghi tra Shemr e Yazìd.
Dopo la distruzione del “tekkiyè statale”, cioè all’epoca dell’instaurazione della monarchia costituzionale, il Ta’ziyè si trasferì nei villaggi e in piccoli centri.
Le necessità sceniche diminuirono e il rapporto tra gli attori si trasformò a tal punto che lo straniamento entrò a far parte dello spettacolo stesso.
Per esempio, fino a qualche tempo fa, gli attori si esibivano con l’ausilio di megafoni elettrici e ora il microfono e gli altoparlanti fanno parte delle abituali necessità tecniche di queste rappresentazioni.
L’imam Hossein parla con Shemr o il gruppo dei nemici, con il microfono in mano. Ma, a causa del credo religioso degli attori stessi, quelli che interpretano i cattivi, sia nel testo che nelle azioni, trattano l’attore che impersona il santo con molto rispetto e al momento della scena del martirio, loro stessi si chinano e piangono, baciando il volto dell’imam.
Queste scene di straniazione non tolgono nulla dall’effetto che lo spettacolo ha sul pubblico anzi, incredibilmente ne aumentano la loro reazione.
Per gli iraniani, il Ta’ziyè è una rappresentazione simile a un rito di purificazione.
Testo di Abbas Kiarostami
(traduzione dal farsì di Babak Karimi)
Pagina aggiornata il 04/03/2025